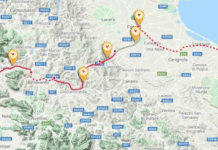Sono nella merda, mamma.
È calato il lavoro? Beh si, ma non per questo. Hai finito le scorte? No, l’altro giorno il Longo… vabbé, nemmeno questo. Sei a secco di sigarette? Nah. Ti senti solo? Nah. Ti mancano gli aperitivi, i concerti, i colleghi? Nah. Vi siete lasciati? Ma va’. Ti manca la tua mamma? Vabbé, ciao. Click.
Per una volta non è un’iperbole. Sono proprio nella merda. Prima che scattasse l’isolamento, nel tardo cenozoico, avevo ordinato su internet tutta una serie di cose in vista della primavera per mettermi a lavorare sul terrazzo, se mai ne avessi trovato il tempo. Perché una volta, casomai qualcuno l’avesse dimenticato, il tempo era sempre poco. Soprattutto per se stessi.
Confesso che trafficare sul terrazzo mi piace e mi rilassa molto,
quei cinque-dieci minuti: poi mi girano le balle. La flora è poco reattiva, per il mio temperamento. Tipo. Piantare il basilico è poeticamente rupestre, prendersene cura è affettivamente bucolico, ma a una certa fatti vedere, stronzetto. Dammelo, un segno di vita. Sono tuo padre, Basilio! Nada. Nel 2006 ho piantato dei bulbi. Qualcuno ha visto dei gladioli sul mio terrazzo? Io no. Di fatto, il terrazzo è popolato esclusivamente da piante dalla resistenza ostinata, temprate a sbocciare anche sul lato oscuro della Luna.
Quest’anno – come ogni anno, per la verità – m’ero messo di buzzo buono e avevo ordinato, dicevo, terra e terriccio e torba e lapilli e corteccia in quantità. Ma soprattutto, clamorosamente sopravvalutando il fabbisogno, una tonnellata di fetido ma efficacissimo stallatico. Una montagna di sterco secco. Complice l’isolamento (soprattutto quello che mi sono imposto dai miei invadenti condomini, che sembrano schegge impazzite), nei giorni scorsi sul terrazzo ci ho dato che ci ho dato, sembravo l’Artemio. Zappa, scava, rinvasa, dissoda, innesta, rimpolpa, semina e concima. Soprattutto, nonostante il palese disgusto di Donna Adelaide, concima.
Ora che è venuto giù il caldo ed è partita l’irrigazione, però, realizzo d’essermi fatto prendere un po’ la mano. Il terrazzo esala un tanfo insopportabile. Una enorme lettiera fetida. In casa fa un caldo soffocante, il riscaldamento condominiale è ancora acceso, e di aprire le finestre non se ne parla, là fuori c’è tanto di quello sterco che sembra il girone dantesco degli adulatori. Del basilico piantato due settimane fa, però, ovviamente neanche l’ombra. Io qua non ci posso stare.
Nel giardino condominiale c’è, o forse c’era, o forse avrebbe dovuto esserci, o forse me lo sono sognato (non lo so. Abito qui da una vita, ma per me è sempre stato un dormitorio) un gazebo o qualcosa del genere, con un tavolo e delle panche in pietra. Decido di installarmi lì per un po’. Tiro su il computer, un paio di pratiche, il solito ambaradan per far finta di lavorare, mascherina guanti occhiali protettivi soprascarpe tuta di neoprene termometro touchless autocertificazione (quattro diverse versioni bilingui si sa mai) scafandro e bombola d’ossigeno, pinne secchiello paletta e scendo allegramente nel cortile.
Strappo alla regola: prendo l’ascensore. Non voglio fare incontri sulle scale, con ‘sta gente non sai mai come va a finire.
L’ascensore non mi piace.
Principalmente perché fa un frastuono d’inferno. Come tutti gli ascensori delle case borghesi fin de siécle di Milano, l’impianto consta di una gabbia in ferro battuto coi meccanismi a vista, all’interno della quale arranca una cabina vetrata in legno lucidato a specchio, che sarebbe più adatta come credenza per i ninnoli delle vedove Speranza anziché per tirar su e giù dei cristiani. Il pavimento è imbarcato e c’è un inspiegabile seggiolino a ribalta che, se ti distrai un attimo, si richiude a scatto spezzandoti il bacino. Quando si muove, il trabiccolo barrisce e cigola e traballa e sbatte, rolla e beccheggia come un vascello nella tempesta, nonostante la spesa per la sua manutenzione sia poco inferiore a quanto spendono gli USA per le missioni oltremare. La verità è che mi terrorizza.
Ad ogni modo, quando si fugge da una valanga di merda non c’è troppo da andare per il sottile. Premo “T” e fino al quarto piano va tutto bene, poi a metà tra il quarto e il terzo piano balz, clang, strunk, ping, sbrott, sbam! il trabiccolo s’inchioda e io rimango intrappolato dentro.
Ricapitolo: sono chiuso in ascensore, di sabato, durante la pandemia.
Constato: dal punto di vista escrementizio la situazione si è, se possibile, aggravata.
Reagisco: premo tasti ad minchiam sulla pulsantiera. Niente.
Questa bara a vetri è decisa a stare inchiodata dove sta.
Potrei invocare l’aiuto divino, ma il trasporto mistico è inibito da una fastidiosa interferenza mentale (animali d’affezione e/o da cortile).
Potrei picchiare la mano sui vetri, ma sono talmente nervoso che potrei recidermi un polso.
Potrei gridare “aìtaaaa”, tipo donzella nella torre, ma in questo palazzo il cavaliere più giovane ha almeno un paio di crociate alle spalle, meglio evitare.
Provo ad aspettare che passi qualcuno ma le scale son deserte, deserte e silenziose, quest’ultima carrozza cigolando s’è bloccata. “Elevatori Rondani Milano”, dice la targa d’ottone, via Principe Umberto 8, mai sentita nominare, Anno XVI E.F., ah ecco, telefono 40415. M’illudo, chiamo, ovviamente numero inesistente. Di un cellulare nessuna traccia. Sulle scale ancora nessuno.
È vietato l’uso dell’ascensore ai minori di anni 12 non accompagnati. Capito? A 14 anni esultai perché potevo vedere i film con la Sandrelli, a 18 potevo guidare, a 25 votare per il Senato, tra meno di due anni potrò essere eletto Presidente della Repubblica: a 12 anni mi sono fumato l’emozionante occasione di poter prendere questa cazzo di trappola per conto mio, mostrando il dito medio al mondo e senza essere accompagnato da un adulto che peraltro, in una situazione del genere, sarebbe sul punto di dare di matto esattamente come lo sono io adesso.
Ora io non so voi, ma poche cose sono più imbarazzanti del dover premere il tasto rosso dell’allarme.
Intendo dire, gli ascensori moderni hanno un bel citofono diretto con la centrale di assistenza: male che vada te la vedi con uno sconosciuto che risponde da chissà dove, ma quantomeno la faccenda resta privata. Una cosa discreta. Questi cessi d’anteguerra, invece, si basano ancora sul fallace e obsoleto principio della solidarietà tra esseri umani. Esigono che tu implori aiuto, cosa che io detesto.
La teoria vuole che, al suono imperioso dell’allarme, i vicini si precipitino fuori dalle loro confortevoli abitazioni accorrendo in tuo soccorso, che il più prestante di loro, a grandi falcate, raggiunga il locale macchine nel solaio e che, manovrando un argano con forza sovrumana, allinei la cabina al piano permettendoti di scendere tra applausi, abbracci, lacrime di commozione, petali di rose e calici di champagne.
La pratica rileva invece che il suono molesto informi all’istante tutti,
ma proprio tutti i tuoi vicini, dello sfigato che sei; che questi, per paura di violare l’isolamento, non escano di casa e ti lascino lì a marcire; che il meno vecchio (perché qui è la foresta pietrificata) si decida ad arrancare sulle scale verso il locale macchine, ma venga colto da malore a metà strada, distraendo su di sé l’urgenza dei soccorsi; che qualcuno chiami l’assistenza, che arriva dopo ore e ti obbliga a strisciare fuori dalla cabina come dentifricio da un tubetto, umiliato e fustigato dagli sguardi irosi dei condomini, che si troveranno il costo dell’intervento sul consuntivo annuale.
Ma non ho scelta. Tasto rosso sia. Le trombe dell’apocalisse, l’avviso termonucleare, l’antiaerea. Un clangore assordante squarcia il silenzio del palazzo. Venghino signori venghino, c’è un pirla chiuso in ascensore! Accorrano numerosi, osservino lorsignori il mostro degli abissi, la donna cannone, il bambino barbuto, l’elefante col fez sul monociclo, il nano forzuto, i fratelli siamesi, l’asino a due teste e l’uomo con tre gambe!
I primi ad “accorrere” (virgolettato d’obbligo) sono il Natale e il Gilberto, terzo piano, formalmente “amici” ma in sostanza sposati da quarant’anni. Una delle coppie più longeve che conosco. Natale, piccolo e nervoso, abita a Milano da quando aveva quindici anni e non ha mai perso la parlata foggiana stretta con la quale zittisce le assemblee condominiali. Ha lavorato come sarto per quelli che sarebbero diventati i più grandi stilisti di Milano, che gli manifestarono la loro gratitudine lasciandolo a fare il sarto tutta la vita. Del che il Natale era loro grato, perché la sartoria è la sua unica ragione di vita oltre al Gilberto, milanese DOCG, che invece ha trascorso la sua vita lavorativa accuratamente imboscato nella tipografia comunale a stampare manifesti funebri. Ipocondriaco e cardiopatico, il Gilberto se ne era già stampate tre o quattro risme del suo, lasciando in bianco solo la data. Avendo vissuto molto di più di quanto immaginava, li affigge nell’atrio condominiale il giorno del suo compleanno per invitarci alla festa.
Una volta ci sono anche andato, a quelle feste,
e devo ammettere d’essermi divertito. L’omosessualità nella Milano degli anni ’70 era roba da uomini veri, un sottobosco fatto di tassisti, mignotte, locali proibiti, cespugli e fosse, emarginazione e violenza. Mica come oggi. Questa è gente che sa divertirsi molto e con poco, hanno sempre tenuto alta la testa. Non c’è un singolo gay in circolazione che non debba a loro qualcosa. Certo: a quelle feste si balla il liscio ambrosiano, una specie di mazurchina lenta ma inesorabile. A fine corsa ti accorgi di aver fatto chilometri, ballando, senza accorgertene.
Li adoro. Adoro anche le loro vestaglie di seta cinese, con le quali si “precipitano” a soccorrermi. Ovviamente il Gilberto ha un mezzo mancamento ed è subito fuori gioco. Dal quarto piano, direttamente dal paleozoccolo superiore, scende giù l’Aurora Britton Ravelli D’Agogna, loro vecchia amica, e fila dritta sul Gilberto senza neanche cagarmi. Natale sbotta in una serie di imprecazioni incomprensibili e si propone, con il suo femore artificiale, d’inerpicarsi verso il locale macchine. Lascia stare Natale, vedi se c’è fuori una targhetta per il pronto intervento. C’è! Chiama quel numero! E’ sc’kattà ‘ncùrpe, vado a prendere il cellulare, e torna col cellulare. Il numero? E che cazzo ne so Natale, io sono chiuso dentro, mica lo vedo! Mo’ te pigghije che ‘na màzze, gli occhiali, va e torna con gli occhialetti mentre io avverto un principio di muffa sulle articolazioni, e finalmente chiama l’assistenza.
L’attesa ha una consistenza diversa da qualunque altra sensazione. È melmosa.
Suona libero. Ancora libero. Estremamente libero. Puzza murì de sùbbete! sbotta Natale, e finalmente qualcuno risponde. La prima spiegazione, mitragliata in pugliese stretto, non va a segno. Colgo lo sforzo fisico di Natale di parlare quello che secondo lui è italiano, quando invece è foggiano lento. L’addetto preposto coglie la situazione e promette che manderà qualcuno a breve.
Frattanto, la notizia del blocco dell’ascensore ha fatto il giro del palazzo, complice questo cazzo di campanello che si sente fino a Brescia e che non smette di suonare. Percepisco nitidamente il vocìo nel cortile, chi mi dà per morto, chi sospetta un incendio, chi i ladri. Realizzo che, finito l’isolamento, dovrò cercarmi un’altra casa, cambiare nome e connotati e soprattutto evitare con cura gli ascensori. Magari un seminterrato.
Contrariamente alle più fosche previsioni, l’addetto all’assistenza è già miracolosamente arrivato. D’altronde i servizi di emergenza funzionano nonostante la pandemia, la gente non esce di casa, gli uffici sono chiusi, non c’è traffico: a ben pensarci non c’era miglior momento di questo, per restare intrappolati in ascensore! Ora sarà questione di attimi, il tizio saprà esattamente dove mettere le mani, gelido e professionale, dopodiché potrò finalmente tornare al mio merdoso terrazzo e mettere fine ai miei giorni buttandomi di sotto.
E invece no. C’è ancora da penare.
Il tizio arriva, avrà la mia età, e mi guarda storto. “Ma tu guarda il caso”. Cazzo non può essere. Lo conosco, è il Mirco Canino detto Caghino. Elementari. Sfintere debole, miope come una talpa, un po’ lento. Parlava sputacchiando. La vittima perfetta, quando io ero lo stronzo perfetto. Non potevo lasciarmelo scappare. Non passò giorno, a scuola, in cui non mi affilassi gli artigli sulla sua pelle. Ero il suo carnefice. Ci siamo persi di vista quarant’anni fa ed è mancata l’occasione per dirgli quanto mi fossi pentito. In realtà non ci ho nemmeno pensato, a pentirmi: finora. Adesso mi sento una merda cosmica: Da aguzzino a vittima in un fiat. Questo, minimo minimo, mi fa precipitare di sotto.
Ostento felicità e commozione per aver ritrovato un vecchio amico. Ma lui non se la beve. Continua a fissarmi picchiandosi la chiave inglese sul palmo della mano. “Bel palazzo, è qua che vivi?” Eh si. “Sei fortunato, da Quarto Oggiaro a qui ci ho messo un attimo”. Ma dai. “Fai l’avvocato, ho sentito”. Eh già. “Quindi sarai a casa in ferie, tu”. Mah. “Io sono reperibile H24, invece”. Beh. “C’è chi nasce fortunato”. Boh. E sta lì. Avverto una fastidiosa mancanza di argomenti di conversazione e, soprattutto, di voglia di farne in quella situazione. Tutti i presenti osservano la scena. Sbotto. “Senti, Caghi… Mirco, scusa, dici che possiamo risolvere? No perché sai, tu sei un rancoroso di merda, io ho i coglioni in polvere e preferirei prender fuoco anziché doverti supplicare” (questo ovviamente non l’ho detto). “Hai paura?” No, ma… “Hai da fare?” No, ma… Ridacchiando vendicativo, il Caghino alza una leva sopra la cabina e il trabiccolo, docile, arriva al piano. Il Caghino mi apre la porta e fa una cosa che mai, mai mi sarei aspettato. Mi abbraccia e mi dice “Mi fa piacere rivederti, avvocato. Sono contento che almeno tu ce l’abbia fatta”.
Rientro a casa frastornato. Ho sempre odiato dover chiedere aiuto. Ma viene un momento in cui non hai scelta, devi chiederlo. Ho sempre pensato che nessuno m’avrebbe aiutato, se avessi avuto bisogno. E invece si sono precipitati tutti, nel condominio in cui vivo. E’ bello, non essere da soli.
Immaginate se, in un momento di difficoltà, avessi chiesto aiuto e m’avessero risposto di arrangiarmi perché il mio terrazzo puzza di merda: come far loro capire che è con quella stessa merda, che fioriscono i loro tulipani?
ANDREA BULLO
Altre storie dalla quarantena di Andrea Bullo:
Milano, ventordicesimo giorno di QUARANTENA
Sono qui che parlo col Sergio. Sergio è il mio LIMONE
Il Porconauta
Il PROFUGO
I CARBONARI della Quarantena
Addio, RENO
VILE ATTENTATO
L’erba del vicino
Le città più internazionali e aperte al mondo sono delle città stato come #Amburgo #Madrid #Berlino #Ginevra #Basilea #SanPietroburgo #Bruxelles #Budapest #Amsterdam #Praga #Londra #Mosca #Vienna #Tokyo #Seoul #Manila #KualaLumpur #Washington #NuovaDelhi #HongKong #CittàDelMessico #BuenosAires #Singapore
SOSTIENI MILANO CITTÀ STATO
Caro lettore, il sito Milano Città Stato è gestito da Vivaio, associazione no profit. Per assicurare contenuti di qualità tutti i collaboratori lavorano senza sosta. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, se ci leggi spesso e se condividi il nostro intento di contribuire a una Milano (e un’Italia) che sia sempre migliore, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci, in particolare in questo momento così delicato. Grazie!