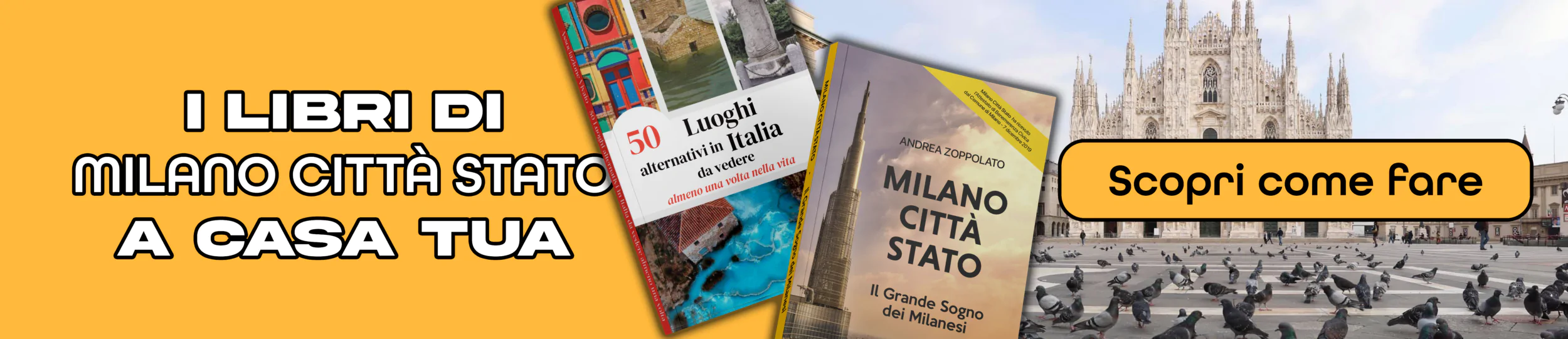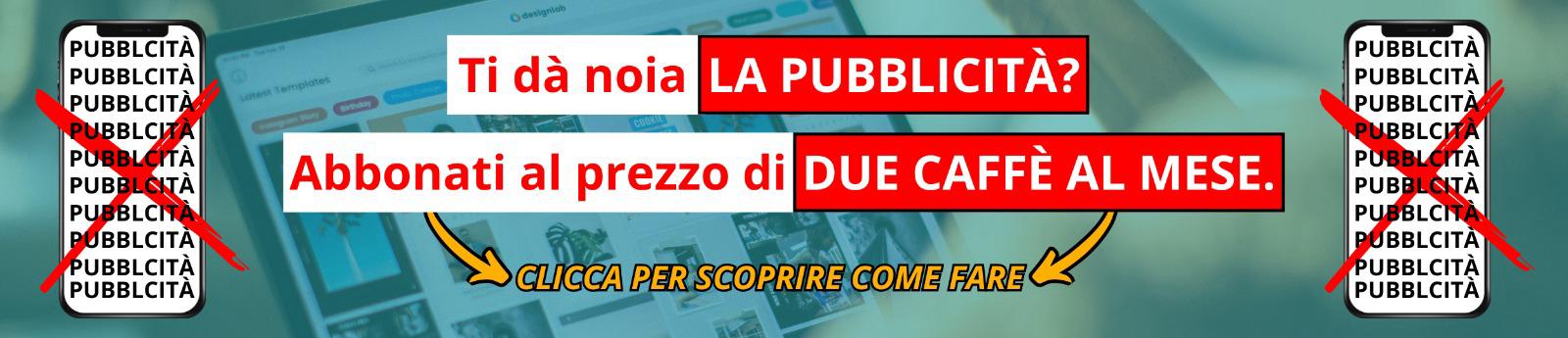In Italia il lavoro è definito dalla Costituzione come fondamento della Repubblica. Ma nella cultura diffusa viene trattato come un sacrificio, assomiglia quasi a una punizione da cui sfuggire per raggiungere la felicità. Il risultato è una distanza crescente tra educazione e realtà lavorativa. Non solo: è una cultura diffusa che favorisce la frustrazione.
# Il lavoro è tenuto fuori dalla formazione dei giovani

Il lavoro? Qualcosa di brutto, di opprimente. Quasi una punizione. Serve solo per poter guadagnare qualche soldo. Questa, in sintesi, la concezione del lavoro secondo la cultura italiana, in particolare nel percorso formativo dei ragazzi. Nel sistema italiano, il lavoro è formalmente separato dal percorso educativo, poiché fino ai sedici anni ogni attività retribuita è vietata, anche se svolta in ambito familiare. Questo proprio perchè lo si vede come qualcosa da cui i giovani devono essere difesi.
Le scuole prevedono l’alternanza scuola-lavoro, ma solo negli ultimi anni e in modo spesso frammentato. Le esperienze precoci sono scoraggiate e raramente valorizzate, mentre i giovani crescono senza confrontarsi con responsabilità operative, regole produttive o vincoli di orario. L’ingresso nel mondo del lavoro avviene dopo la scuola, senza passaggi intermedi, e viene presentato come qualcosa di esterno e successivo, mai come fase del processo formativo. La divisione tra studio e attività produttiva è istituzionale e culturale: anche molte famiglie tendono a proteggere i figli da ogni contatto anticipato col lavoro, e l’approccio dominante continua a considerare il lavoro come un ostacolo allo sviluppo, non come strumento di formazione.
# Germania e Stati Uniti prevedono l’integrazione del lavoro

In Germania e negli Stati Uniti il lavoro è introdotto in modo graduale già durante il percorso scolastico: negli USA i giovani possono svolgere impieghi part-time dai quattordici anni, regolati ma diffusi, mentre il lavoro è visto come occasione per apprendere autonomia, gestione del tempo e responsabilità. In Germania, invece, gli studenti delle scuole secondarie partecipano a tirocini obbligatori, di una o due settimane, presso aziende o enti pubblici, che rappresentano esperienze curricolari riconosciute come parte della formazione. Il sistema tedesco prosegue con il modello duale, che unisce lezioni teoriche e attività in azienda. In entrambi i casi, il lavoro è parte normale del percorso di crescita: le istituzioni lo regolano e accompagnano, ma non lo escludono. La separazione tra formazione e produzione non è rigida, poiché l’esperienza concreta è considerata formativa fin dalle prime fasi.
# Il lavoro è un elemento fondamentale nel processo di autorealizzazione
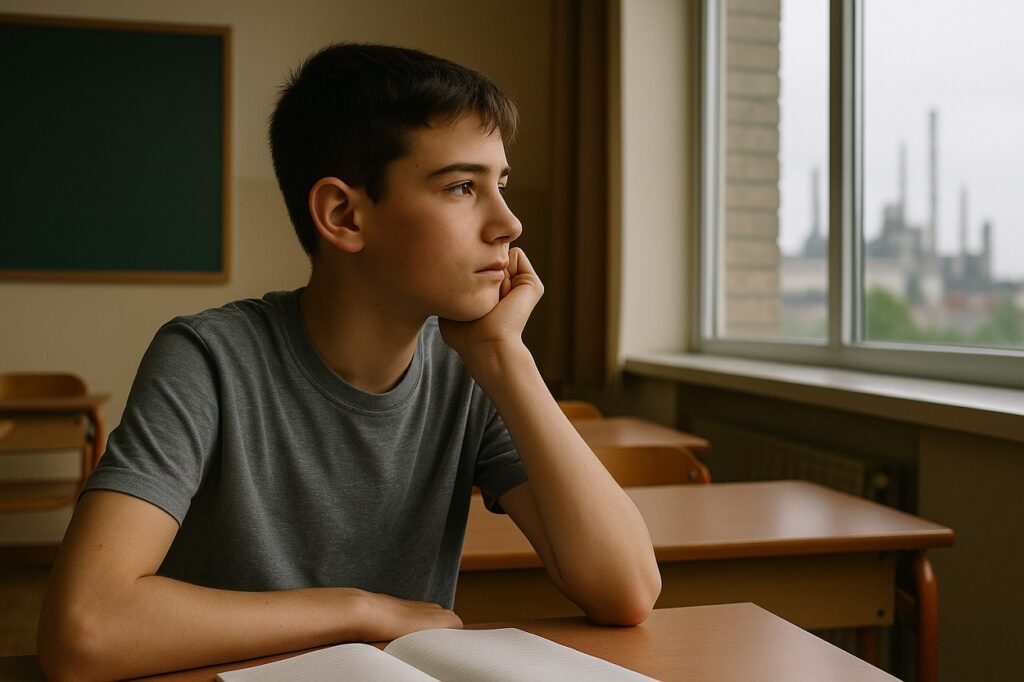
La vita è ciò che si trova al di fuori del posto di lavoro. Questo sembra il mantra che viene inculcato nella nostra mente. Ma è proprio così? Tutti i più grandi filosofi e psicologi di stampo umanistico dicono l’esatto contrario. Il lavoro è parte fondamentale del processo di autorealizzazione individuale. Rappresenta un percorso di crescita e di gratificazione.
Nel modello italiano, invece, il lavoro non è mai presentato come fase di sviluppo personale, ma piuttosto come una transizione brusca e posticipata che avviene senza allenamento e il cui solo orizzonte di speranza è rappresentato da weekend, ferie e pensione. Questo comporta due gravi distorsioni:
- considerando il lavoro in ottica estranea al percorso formativo, i giovani non vengono preparati per essere dei protagonisti nella loro carriera, ma vengono formati a una dipendenza mentale e di competenze che rischia di svilire il loro valore
- in secondo luogo, se si trasmette l’idea che la vita sia ciò che sta al di fuori del lavoro, si destinano le persone a un’esistenza infelice, in cui la gran parte del proprio tempo è dedicata alla sofferenza e alla mancanza di senso esistenziale.
L’Italia continua a trattare il lavoro come un evento traumatico, non come processo educativo. E l’effetto è quello di avere una società frustrata, infelice, che riconduce ogni fine a quello di prendere uno stipendio a fine mese e di difendere a tutti i costi il proprio luogo di sofferenza esistenziale.
Continua la lettura con: Un reddito medio non basta per una casa neppure nei dintorni di Milano: lo studio
FABIO MARCOMIN