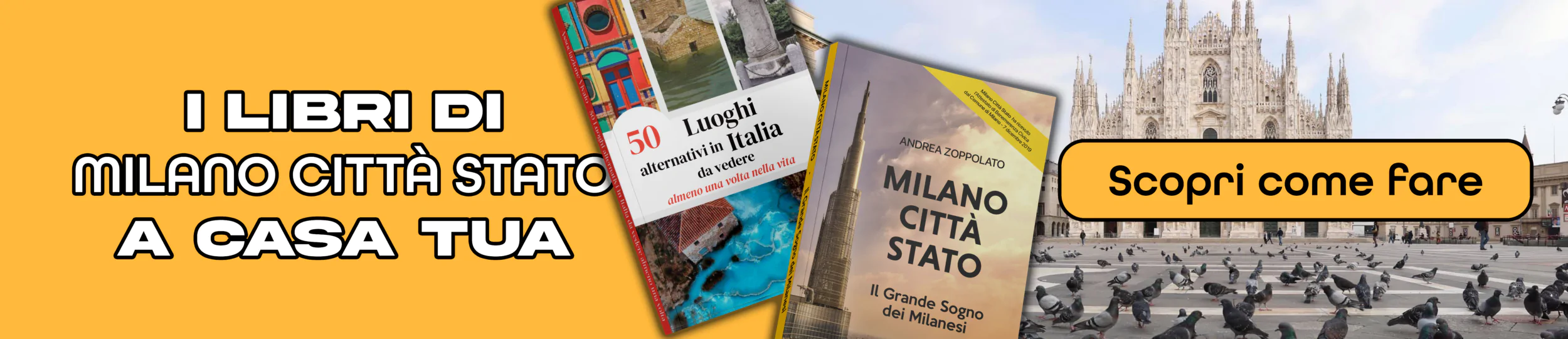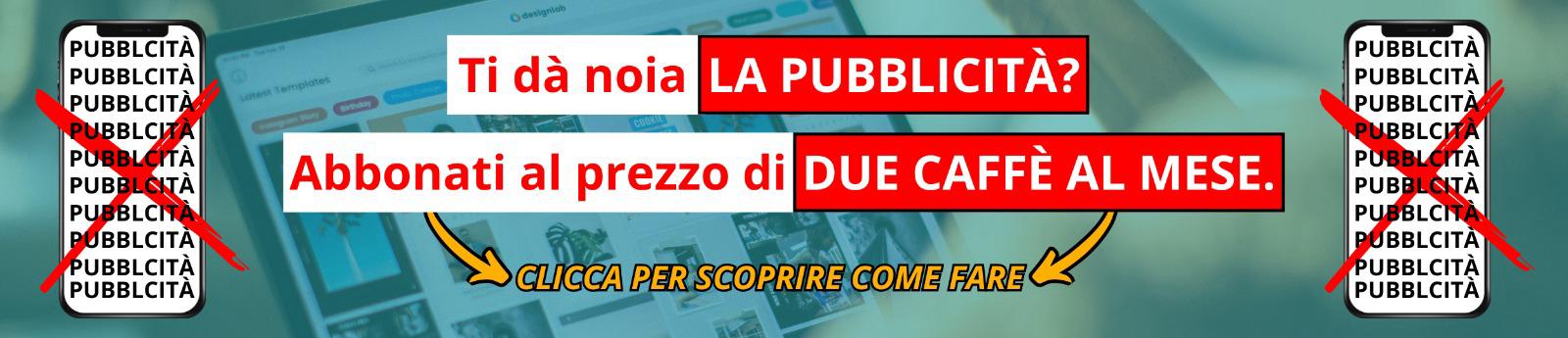Un elenco di abitudini e scenari estivi che appartenevano alla Milano di un tempo. Alcune cose ci sono ancora ma sono molto diverse da allora.
#1 Bagni nei Navigli

Fino alla metà del ‘900, il bagno nei Navigli era una consuetudine diffusa. I tratti più frequentati erano quelli del Naviglio Grande e della Martesana. Nei punti di balneazione si trovavano strutture galleggianti in legno, i cosiddetti bagni diurni, dotati di spogliatoi e zone delimitate per l’immersione. Il primo bagno pubblico fu istituito nel 1887 presso il Ponte delle Gabelle, sul Naviglio Martesana, con paratie di legno, cabine e accesso solo maschile. Non si trattava di luoghi ricreativi, ma di spazi per l’igiene estiva, come conferma una testimonianza del 1910.
#2 Il silenzio dei cortili
Negli anni Cinquanta e fino agli Ottanta, le case di ringhiera si svuotavano durante l’estate. Interi nuclei familiari partivano per settimane, lasciando Milano e i suoi cortili immersi nel silenzio. I pochi rimasti erano anziani, gatti, e qualche passante occasionale. Il contrasto con la frenesia del resto dell’anno era netto. Le saracinesche abbassate, il rumore attutito dei tram, i giochi dei bambini sostituiti dal vuoto. Oggi la città non si svuota più, tra turismo, affitti brevi e nuove modalità lavorative, i cortili non restano deserti.
#3 I gelatai con i carrettini

Durante l’estate, gelatai ambulanti percorrevano le strade con carrettini spinti a mano o su biciclette. Erano riconoscibili per i carrelli bianchi e per i richiami sonori: campanelli, fischietti o trombette. I bambini li attendevano sotto casa. All’interno si trovavano granite, ghiaccioli e gelati mantenuti freddi con salamoia e blocchi di ghiaccio. Era una presenza fissa dell’estate milanese. Oggi questi carrettini sono scomparsi quasi del tutto, al loro posto ci sono chioschi fissi, gelaterie o moderni food truck. Il contatto diretto con il quartiere si è perso.
#4 L’Idroscalo “del popolo”

Inaugurato nel 1930 come scalo per idrovolanti, l’Idroscalo divenne negli anni ’50 un luogo di svago per le famiglie. Raggiunto in tram o in bicicletta, veniva vissuto come una spiaggia urbana. Si stendevano asciugamani sul prato, si portavano panini e radio. Era frequentato da famiglie operaie, comitive di ragazzi, circoli dopolavoro. L’ingresso era libero e l’atmosfera informale. Oggi l’Idroscalo esiste ancora, ma è stato trasformato in un centro sportivo e per eventi, più patinato. Le aree attrezzate hanno preso il posto dei prati affollati, rimasti solo in minima parte. Ha perso parte del suo spirito spontaneo.
#5 Le colonie estive per i bambini milanesi
Negli anni ’50, ’60 e ’70, molti bambini milanesi venivano mandati in colonia estiva, organizzata dal Comune, dalle parrocchie o da grandi aziende come Pirelli, Falck, ATM, Alfa Romeo. Le destinazioni erano località di mare o montagna, in Liguria, Emilia o Trentino. Si partiva in gruppo, spesso in treno o in pullman, con la targhetta al collo e la valigia di cartone. Il soggiorno durava settimane, tra orari rigidi, pasti comuni, giochi e nostalgia. Per molti era l’unica vacanza possibile. Oggi le colonie esistono ancora, ma sono più brevi, a pagamento e con minore funzione educativa e collettiva.
#6 Balere all’aperto nei quartieri

L’estate milanese comprendeva anche serate danzanti nei cortili e nei circoli. Le balere all’aperto ospitavano mazurche, tanghi, valzer e liscio. La musica era suonata da orchestre locali e si ballava tra amici, in famiglia o con sconosciuti. Le serate erano gratuite o a offerta libera. Era una forma di aggregazione accessibile e diffusa, radicata nei quartieri. Oggi le balere esistono ancora, ma in forma diversa. Sono eventi per appassionati o rievocazioni storiche e hanno perso la funzione quotidiana di socialità estiva.
#7 Sagre e feste di quartiere
Durante l’estate si svolgevano numerose sagre e feste popolari in tutta la città. Erano organizzate da parrocchie, associazioni o comitati di quartiere. I programmi prevedevano tombole, giochi per bambini, grigliate, balli e pesca di beneficenza. Si tenevano in cortili, piazze o campi sportivi. Erano occasioni di incontro comunitario. Oggi alcune sagre sono sopravvissute, come la Sagra di Baggio, ma sono cambiate. Sono più strutturate, spesso sponsorizzate, e meno spontanee. La dimensione locale è stata in parte sostituita da una logica di evento.
Continua la lettura con: Milano con il cuore in mano: le cose che ognuno di noi potrebbe fare per la città
FABIO MARCOMIN